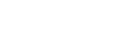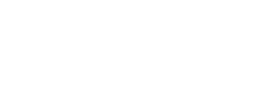L’ISOLA DI ARTURO - 1
1957: Elsa Morante è la prima donna a vincere il Premio Strega per L’isola di Arturo.
DUE POSSIBILI LETTURE DEL ROMANZO
- La prima rimanda al mito e alla fiaba.
- La seconda lo considera un racconto realistico, con riferimenti autobiografici.
Chi propende per la prima lettura sottolinea come l'isola abbia «un significato abbastanza costante nel mito, nella fiaba, nel repertorio dei simboli magicopsicologici», poiché è il luogo nel quale l'eroe si ritrova «naufrago dello smarrimento» e viene sottoposto a prove iniziatiche.
La prima infanzia di Arturo, inoltre, è simile a quella di molti eroi: viene al mondo in circostanze drammatiche, allattato da un umile garzone con latte di capra, nascosto in una cassetta di pasta per non essere rapito dai parenti materni, proprio come avvenne per Mosè.
Fin dalla prima pagina, il protagonista è presentato come un archetipo leggendario, in quanto porta il nome del mitico re dei cavalieri della tavola rotonda e quello della stella del carro di Boote.
La seconda tesi, che vede ne L'Isola un libro di memorie narrate in forma autobiografica, è accreditata dalla Morante stessa, che dà al suo romanzo il sottotitolo Memorie di un fanciullo.
Nata a Roma nel 1912, Elsa e i suoi fratelli minori erano figli di un’insegnante, di religione ebraica, Irma, e di un uomo siciliano di nome Francesco Lo Monaco, tutti riconosciuti dal marito di lei, Augusto Morante, ma concepiti al di fuori del matrimonio.
Per questo Elsa, come il suo giovane protagonista, fu indotta a lasciare molto presto la famiglia. Scrive l’autrice:
Io avrei voluto con questo libro scrivere una storia che somigli in certe cose a Robinson Crusoe, cioè la storia di un ragazzo che scopre per la prima volta tutte le cose più grandi, più belle e anche quelle brutte della vita; per lui tutto è avventura, è stupore, è bellezza perché vede le cose per la prima volta e non ha nessuna esperienza né del bene né del male. E siccome vive in una delle isole più belle che io abbia mai conosciuto, che è l'isola di Procida, tutto quello che gli cade sotto gli occhi è di una particolare bellezza e quindi a lui la vita appare sotto un colore fantastico. Forse per questo qualcuno ha parlato di una fiaba ma per me il mio libro è uno dei più reali che siano stati scritti in questi ultimi tempi.
Morante precisa, in un saggio sul romanzo:
Romanzo sarebbe ogni opera poetica, nella quale l'autore - attraverso la narrazione inventata di vicende esemplari (da lui scelte come pretesto, o simbolo delle relazioni umane nel mondo) - dà intera una propria immagine dell'universo reale (e cioè dell'uomo, nella sua realtà).
Come ogni altra viva esperienza umana, difatti, l'arte non può nutrirsi che di realtà. […] La realtà corruttibile dev'essere tramutata, da lui (il romanziere), in una verità poetica incorruttibile. […] Un vero romanzo, dunque, è sempre realista: anche il più favoloso!
Si può dire che, ne L’isola di Arturo, realtà e fiaba sono intrecciate?
Oppure che gli elementi realistici hanno un sapore fiabesco?
QUESTIONE DEL NARRATORE
Morante utilizza la prima persona, tipica dei racconti autobiografici. Ma il suo io narrante è molto diverso, ad esempio, da quello di Nievo.
In questo racconto, non si sente il piacere di recuperare le proprie memorie, di abbandonarsi ad esse, talvolta idealizzandole, ma un distacco netto, che sfiora la freddezza della non partecipazione.
A volte, però, si avverte “lo scarto dell'esclamazione, il concitato discutere ed analizzare le proprie ragioni da parte del protagonista”.
In quei momenti, ci troviamo dinanzi ad un vero e proprio sdoppiamento, come se il narratore scegliesse di tornare a vestire i panni del fanciullo, assumendone totalmente la prospettiva. È come se l’io narrante si sottoponesse a un’introspezione profonda, proiettandosi in un altro io lontano nel tempo.
I PARTE – RE E STELLA DEL CIELO
La madre di Arturo è morta dandolo alla luce, e il piccolo è sopravvissuto nei primi anni di vita grazie alle amorevoli attenzioni del balio Silvestro. Wilhelm Gerace, il padre del bambino, è quasi sempre in viaggio per motivi misteriosi, sui quali Arturo non smette mai di fantasticare, arrivando ben presto a mitizzare la figura paterna.
L'infanzia del protagonista è caratterizzata dalla solitudine di cui però egli non soffre, poiché la sua fervida immaginazione e le bellezze naturali della terra natia non gli permettono di annoiarsi; egli sa sempre come trascorrere il proprio tempo in perfetta sintonia con sé stesso e l'ambiente circostante.
Wilhelm Gerace è un padre fuori dall'ordinario: non è lui a occuparsi del figlio appena nato e orfano di madre e le sue assenze superano la sua presenza nell'isola:
Un paio di mesi dopo la mia nascita, mio padre era partito dall’isola per un’assenza di quasi mezz’anno: lasciandomi nelle braccia del nostro primo garzone, che era molto serio per la sua età e mi allevò con latte di capra. Fu il medesimo garzone che mi insegnò a parlare, a leggere e a scrivere. […] Mio padre non si curò mai di farmi frequentare le scuole.[…] A fare la somma dei suoi rari e brevi soggiorni sull’isola, alla fine dell’anno, si sarebbe trovato che, su dodici mesi, egli forse ne aveva passato due a Procida, con me.
Nonostante le sue assenze, Wilhelm è avvolto da un alone leggendario, come dimostrano le parole di Arturo:
Consideravo ogni soggiorno di mio padre sull'isola come una grazia straordinaria da parte di lui, una concessione particolare, della quale ero superbo.
Gli oggetti di Wilhelm esercitano un fascino indiscusso sulla fantasia di Arturo: una maschera per guardare il fondale marino, un fucile, un binocolo e soprattutto un orologio da polso marca Amicus segnano la complicità tra padre e figlio.
Continui e vani sono gli sforzi del ragazzino di attirare l'attenzione paterna: Cercavo sempre l'occasione di mostrarmi valoroso e impavido ai suoi occhi. L'occasione d'oro si verifica quando il padre teme di aver smarrito tra le onde l'orologio Amicus e Arturo di fatto riesce a ritrovarlo ma ottiene il rimprovero per aver distratto il genitore con la pesca dei ricci di mare.
Arturo gli riconosce una superiorità quasi regale: egli primeggia per l'altezza rispetto ai procidiani e la sua bellezza nordica (la madre infatti era tedesca) contrasta con i colori scuri della carnagione mediterranea:
Il suo corpo, nell'estate acquisiva uno splendore bruno carezzevole, imbevendosi del sole, pareva, come d'un olio; ma nella stagione invernale ritornava chiaro come le perle. E io, che ero sempre scuro in ogni stagione, vedevo in ciò quasi il segno di una stirpe non terrestre.
Tutte le sue azioni, anche le più banali, si caricano di un significato eroico, come quando urla ingiurie incomprensibili in tedesco e l'eco ne amplifica la gravità:
Non mi pareva d'assistere al solito gioco dell'eco, assai comune fra i ragazzi; ma a un duello epico. Siamo a Roncisvalle, e d'un tratto, sulla spianata, irromperà Orlando col suo corno. Siamo alle Termopili, e dietro le rocce si nascondono i cavalieri persiani, coi loro berretti puntuti.
Il verbo del padre è inviolabile e ispira in Arturo quel Codice delle Verità Assolute cui il bambino presterà fede per tutta la fanciullezza.
Fino al momento traumatico della crisi, Wilhelm è per il figlio una figura di riferimento indiscussa.
Quali IMMAGINI ci restano impresse più di altre dopo aver letto la prima parte del romanzo?
La bellezza dell’isola, simile a quella di Wilhelm Gerace
Una bellezza fatta di luce e ombra. Le scontrosità di W. G. forse dipendono dal suo passato difficile: (“il suo cuore doveva essersi nutrito di rancore…”)
Padre e figlio: una buffa coppia
Dovevamo essere una buffa coppia, per chi ci incontrava! Lui che avanzava risoluto, come una vela nel vento, con la sua bionda testa forestiera, le labbra gonfie e gli occhi duri, senza guardare nessuno in faccia. E io che gli tenevo dietro, girando fieramente a destra e a sinistra i miei occhi mori, come a dire: “Procidiani, passa mio padre!”.
La casa dei guaglioni, “malefica e meravigliosa”, isolata su un colle, simile a un palazzo con inferriate barocche, piena di segreti e ricordi che la nobilitano e la rendono diversa da tutte le altre case dell’isola (il convento, l’Amalfitano e le sue feste).
Ai tempi di Arturo è una casa in completo abbandono. “Nessuno si dava pena del disordine e del sudiciume delle nostre stanze, che a noi pareva naturale come la vegetazione del giardino incolto fra le mura della casa.”
Altra caratteristica della casa è di essere vietata alle donne, fino alla comparsa di Nunziata.
Le donne sono assenti, in questa prima parte del romanzo: abbiamo solo l’immagine delle isolane, vestite di nero, brutte e sfuggenti.
In contrasto con esse, Arturo ha costruito il ricordo di sua madre, intravista in una piccola foto sbiadita, eppure elevata a un rango sublime. Il padre la nomina molto raramente e “la sua voce, su quel nome, sembra raccogliersi per un attimo quasi teneramente, e poi subito sorvolare via”.
Arturo non ha certezze riguardo alle donne, che di fatto sono escluse dal suo codice, come dalla casa dell’Amalfitano. Egli teme che anche sua madre fosse stata esclusa dal grande amico del padre (e quindi, in parte, anche da lui).
W.G. non parla neppure di un’altra morta, la nonna tedesca, ma basta un suo accenno negativo, quando Arturo ritrova una foto, perché lui la immagini come “una Orchessa, o altra peste simile”.
L’immagine di una femminilità piena di dolcezza e di grazia è invece rappresentata da Immacolatella, la cagnetta bianca, sua compagna di giochi. Essa muore di parto, come la madre di Arturo.
Gli amici del padre sono importanti per Arturo, ma per lui irraggiungibili. Romeo l'Amalfitano è morto da tempo.
Pugnale algerino rappresenta nello stesso tempo delusione e desiderio: solo crescendo e diventando come lui Arturo potrebbe condividere la vita del padre e accompagnarlo nei suoi viaggi.